Bussana Vecchia è un antico borgo medievale caratterizzato dalla struttura a «pigna» tipica di molti nuclei abitati dell’entroterra imperiese. Frazione collinare del Comune di Sanremo, dista circa 8 km dal capoluogo.
di Diego Vaschetto.
Bussana Vecchia è costruito su un promontorio interessato da imponenti fenomeni erosivi di tipo calanchivo che agiscono sui suoi versanti, rimanendo nonostante tutto relativamente verde, circondato da una fitta vegetazione costituita dalla macchia mediterranea, cui si alternano boschi di castagni e ridotte pinete di pini marittimi.

Scorcio di un carruggio e delle tipiche abitazioni di Bussana Vecchia con il campanile della parrocchiale.
La storia
Sembra che il paese sia stato fondato in epoca romana con il nome originario di Armedina o Armedana; ma è solo dal VII secolo che si hanno testimonianze certe di un primo stanziamento sul colle, in seguito alle incursioni dei Longobardi che spinsero la popolazione ad abbandonare le abitazioni ubicate nella sottostante valle Armea. Nel X secolo le frequenti invasioni saracene costrinsero gli abitanti di questi luoghi a rifugiarsi di nuovo in posti più elevati e più difficili da attaccare, con conseguente edificazione spontanea delle prime strutture difensive sulla collina di Bussana. Il primo vero castello risale al periodo tra il 1162 e il 1177, quando il borgo cadde sotto il controllo dei conti di Ventimiglia, che ne potenziarono le difese. Nel XIII secolo il paese venne acquistato dalla repubblica di Genova, che lasciò una relativa indipendenza ai circa duecentocinquanta abitanti. Nel frattempo l’originale castello perse la propria funzione difensiva, per diventarestruttura residenziale dotata di una cappella annessa che tutt’oggi funge da luogo di culto per gli abitanti del paese. Nel 1404 venne completata la prima chiesa, edificata sui resti di una precedente, e fu dedicata a Sant’Egidio. A partire dal XV secolo, in seguito a un forte incremento demografico, iniziò lo sviluppo edilizio del paese, caratterizzato da un mutamento delle tecniche costruttive delle murature: l’impiego di pietre quadrate di uso romano venne sostituto dall’uso di pietre arrotondate provenienti dalle vicine spiagge rocciose e ciottolose. Nel XVI secolo il paese si allargò alla zona sudest, ed è a questo periodo che risalgono quasi tutte le costruzioni oggi presenti. Il XVII secolo vide la completa ricostruzione della chiesa, che dallo stile romanico originale divenne barocca, mentre il castello, dopo secoli di abbandono, cadde del tutto in rovina.

La via degli archi, strutture realizzate nell’Ottocento per proteggere le case dai sempre più frequenti terremoti.
I terremoti
Per oltre due secoli l’abitato rimase in pratica immutato, con un’economia rurale che gravitava attorno alla coltura degli olivi e degli alberi di agrumi, disposti lungo i pendii terrazzati. A partire dal XIX secolo cominciarono a manifestarsi i primi timori relativi alla sismicità del luogo, tuttora considerato ad alto rischio. Nella prima metà dell’Ottocento si registrarono alcuni terremoti di un certo livello, che si ripeterono nel 1831, 1851 e 1854, tanto che la popolazione decise di rinforzare gli edifici esistenti introducendo archetti che, all’altezza del primo o del secondo piano, collegano le abitazioni che si affacciano lungo i viottoli dell’antico borgo. Alle 6:21 del 23 febbraio 1887, mercoledì delle Ceneri, si verificò la scossa di terremoto che segnò per sempre il destino del paese. A quell’ora buona parte della popolazione si trovava in chiesa per seguire la messa. In soli venti secondi il sisma provocò morti e danni incalcolabili: fece crollare la volta della gremita chiesa e la quasi totalità delle abitazioni della parte alta del villaggio venne distrutta, seppellendo sotto le macerie centinaia di persone. I sopravvissuti decisero dapprima di accamparsi nella zona bassa del paese, in attesa di capire se fosse possibile recuperare in qualche modo le costruzioni meno lesionate e ricostruire le abitazioni crollate, ma la decisione delle autorità fu di sgomberare del tutto la zona spostando gli abitanti nell’area più bassa e adiacente al mare del costone che chiude da est la valle del torrente Armea. Anche se la maggior parte della popolazione si oppose al trasferimento, poiché avrebbe preferito ampliare il borgo originario ricostruendo le abitazioni più danneggiate, il vivo ricordo del terremoto e le imposizioni delle autorità convinsero i residenti a fondare il paese di Bussana Nuova, che venne edificato tra il 1889 e il 1894, anno in cui i bussanesi abbandonarono definitivamente il borgo originario, dopo aver celebrato un’ultima messa nella domenica delle Palme.

I ruderi della parrocchiale di Bussana Vecchia distrutta dal terremoto del 1887.
La rinascita
Il paese, da quel momento chiamato Bussana Vecchia, rimase in stato di totale abbandono per oltre mezzo secolo fino a quando, sul finire degli anni Cinquanta del XX secolo, ricominciò a essere abitato da una comunità di artisti italiani e stranieri che, attratti dalla particolarità del luogo, cominciarono a ristrutturare gli edifici meno danneggiati rendendoli di nuovo abitabili, pur senza i servizi della luce e dell’acqua corrente. Oggi la borgata ospita una comunità internazionale di artisti, con botteghe artigiane e alcuni punti di ristoro, che l’hanno trasformata in un caratteristico «villaggio di artisti» con una romantica ambientazione da borgo medievale. La visita del pittoresco nucleo abitato è una continua scoperta: ovunque vi sono angoli molto caratteristici, anche per l’estrema attenzione dei residenti nel mantenere l’originale aspetto ottocentesco del borgo e il suggestivo connubio di edifici ristrutturati e resti diroccati di antiche abitazioni. Anche la vecchia chiesa di Sant’Egidio, visitabile solo dall’esterno, è rimasta allo stato successivo al terremoto, con la volta ormai scomparsa e poche tracce degli stucchi e delle pitture originarie. Il campanile della chiesa, scampato per miracolo al sisma, è considerato dagli abitanti di Bussana Vecchia come il simbolo del paese. Da decenni ormai la presenza di artisti provenienti da tutto il mondo ha favorito lo sviluppo di manifestazioni che si svolgono stagionalmente nel villaggio medievale: le esibizioni teatrali, le esposizioni d’arte e la musica dal vivo, soprattutto nelle sere d’estate, sono ormai divenuti noti avvenimenti, frequentatissimi e attesi di anno in anno.

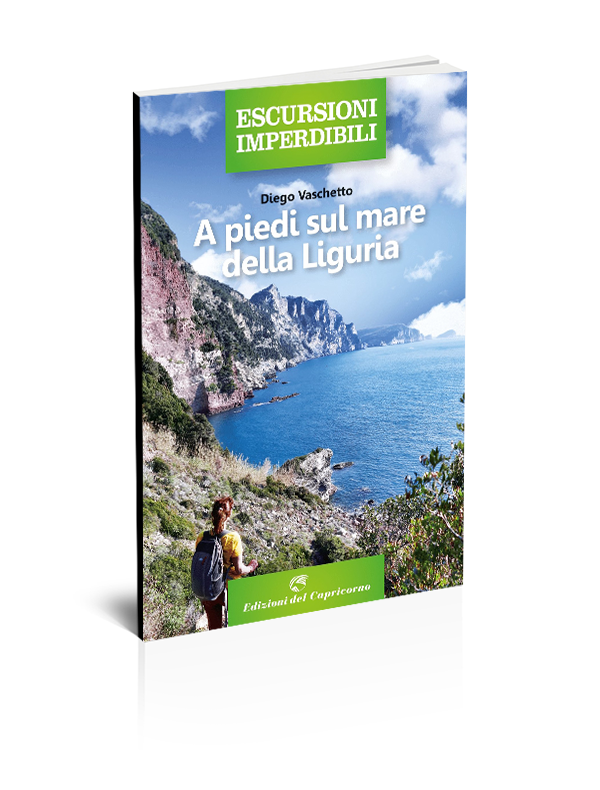







Lascia un commento