Nostra Signora del Carmine a Genova conserva una decorazione dell’abside duecentesca, che recenti restauri hanno permesso di riscoprire nella sua bellezza.
Di Ilario Manfredini.
Nostra Signora del Carmine a Genova sorse ai piedi delle alture dell’Olivella e di Carbonara, nel luogo dove si trovava un’antica cappella intitolata all’Annunziata tra il 1262 e l’inizio del XIV secolo, nei decenni che videro svilupparsi numerosi insediamenti monastici in una città sempre più potente. Nel Trecento furono edificati il convento, distrutto nel 1870 per tracciare la nuova strada di accesso all’Albergo dei Poveri, e il chiostro, di cui resta qualche traccia. La chiesa, nata a una sola navata, fu ampliata una prima volta nel XV secolo e poi ancora modificata nel Cinquecento, con l’apertura delle cappelle esterne nella navata destra, e infine nell’Ottocento.

Nostra Signora e Sant’Agnese, interno, navata est (foto Zairon). Sotto, il rosone del coro.
Gli interni
L’interno a tre navate conserva un’impronta gotica, resa visibile dai restauri del 1928-36 che hanno rimosso gli ornati ottocenteschi, uniformando tutti gli elementi della chiesa all’originale bicromia bianca e nera. La chiesa conserva al suo interno importanti cicli pittorici medievali. Già a fine Duecento era iniziata la decorazione dell’abside rettangolare, che recenti restauri hanno permesso di riscoprire nella sua bellezza.
Nella sezione superiore, accanto al rosone, sono raffigurati l’Arcangelo Gabriele e la Vergine annunciata, separati dalla parte bassa da una fascia sottostante l’imposta dell’arco decorata a fogliami, con due oculi con santi carmelitani a mezza figura.
Ai lati, sottostanti le tre finestre, il restauro ha portato alla luce le figure sovrapposte di san Giovanni Battista e del profeta Elia, un vecchio barbuto con l’abito carmelitano, a sinistra, e di san Bartolomeo e di santa Margherita di Antiochia a destra. I quattro personaggi sono ospitati a due a due in un’edicola che ricorda un baldacchino a pinnacoli di gusto gotico, sorretto da colonne tortili.
La parete di sinistra presenta, nella sezione superiore, tre oculi a conci bianchi e neri, dei quali quello centrale ospita un’aquila, mentre la fascia sottostante si caratterizza per un fregio fogliato anch’esso con tre oculi, che ospitano san Paolo e due santi carmelitani. Nella parte bassa della parete, ancora in parte da restaurare, si può intravedere la figura di sant’Alberto da Vercelli, che scrisse la regola dell’Ordine.
Nella parete di destra le pitture sembrano appartenere a una campagna di lavori precedente rispetto a quella di sinistra, risalente al primo Trecento, per via di alcune decorazioni geometriche tipiche della pittura di matrice romanica. Gli affreschi furono realizzati dopo il 1287, dal momento che Elia e gli altri santi carmelitani indossano l’abito bianco, che sostituì proprio in quella data il manto rigato usato in precedenza.

Il problema dell’attribuzione
Sull’attribuzione del ciclo di Nostra Signora del Carmine a Genova la critica ha proposto una serie di nomi, primo fra tutti Manfredino da Pistoia, che avrebbe dipinto il ciclo carmelitano poco prima o poco dopo quello di San Michele a Fassolo. Si tratta di una fondazione antichissima, di cui si hanno notizie risalenti addirittura al VII-VIII secolo.
Nel periodo romanico la chiesa, a tre navate, era collegata con una struttura conventuale, che con il XV secolo cominciò a essere abbandonata e cadde in disuso. La costruzione della mura nuove cinquecentesche portò a una parziale distruzione della chiesa che fu privata della parte anteriore, conservando solo transetto e absidi, assumendo la forma un po’ curiosa che alcuni pittori immortalarono nell’Ottocento, poco prima che questo storico edificio venisse distrutto.

Pittore romanico, santo carmelitano.
L’ombra di Cimabue
Collaboratore di Cimabue ad Assisi, Manfredino si reca a Genova alla fine del XIII secolo e qui esegue nel 1292 alcuni affreschi nella chiesa di San Michele di Fassolo, strappati nell’Ottocento. Si tratta di un San Michele Arcangelo e della Cena di Betania, due delle opere più importanti conservate nel Museo di Sant’Agostino di Genova. In ogni caso, l’autore dimostra di essere ben aggiornato sulle ultime novità della pittura centroitaliana, e la sua presenza a Genova influenzerà sia la committenza cittadina sia il linguaggio figurativo degli artisti qui attivi alla fine del XIII secolo.
Gli affreschi di Nostra Signora del Carmine a Genova rimandano a una comune ascendenza cimabuesca, che si distanzia dalle precedenti influenze bizantine caratterizzanti gran parte della produzione dell’artista toscano. Allo stato attuale delle conoscenze, gli studiosi non si sbilanciano sul possibile nome del pittore, ritenenedo necessaria una serie di approfondimenti, a partire dal riesame degli aiuti di Cimabue.
Nonostante la grande importanza che questi affreschi ebbero per lo sviluppo della pittura genovese, non si conservano in città opere che rimandano all’esperienza cimabuesca presente nella chiesa del Carmine. L’unico dipinto avvicinabile risulta l’angelo, simbolo di san Matteo, raffigurato nella vela di una delle campate centrali della chiesa di Sant’Agostino.

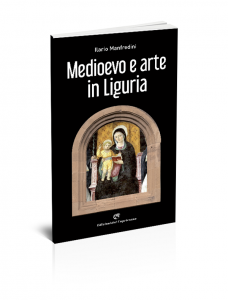







Lascia un commento